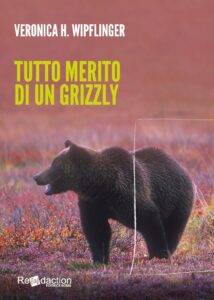Sorelle e fratelli, Distinte Autorità, Chiesa di Nocera Inferiore-Sarno pellegrina nell’amata terra dell’Agro, torna puntuale il Discorso alla Città, legato al Patrono San Prisco, segno permanente e gravido di
Speranza per la nostra gente.
Tanti sono i segni di speranza presenti tra noi, a volte forse offuscati e non valorizzati; e segni di speranza sono le tante preghiere, alle quali ci affidiamo delle oranti e degli oranti, e che tante persone pie
elevano incessantemente verso il Cielo della nostra speranza, e contribuiscono in modo determinante a edificare la Città (cfr Sal 127), sempre pallida immagine della Città Santa (cfr Ap 21, 9-27).
Tempo ricco di speranza è l’Anno Santo che stiamo vivendo, con l’invito a far riposare la terra, riconciliarsi (cfr Lev 25), e con i segni eloquenti del Pellegrinaggio e della Porta Santa, verso la quale
tanti Pellegrini di Speranza sono in cammino con il
cuore e i piedi. Tempo di gioia, di pace, di riconciliazione, temi
ai quali sempre ci richiama la voce del Santo Padre,
quasi jobel, che annuncia un tempo di grazia (cfr Lc 4, 14-19).
Segno di speranza è il sessantesimo anniversario della Costituzione pastorale Gaudium et spes (7 II 1965); e della conclusione dell’Assise conciliare (8 dicembre 1965). Tanti sono i segni di speranza, ed Admirabilem signum (Francesco, 1 dicembre 2019) è anche il
Presepe che la nostra Diocesi offrirà al Santo Padre nel prossimo Natale giubilare, quasi icona di un mondo che sempre deve rinascere sulle cose essenziali. Ed è il Presepe, quest’anno, che ci offre lo spunto per il tema del Discorso alla Città: Nel Presepe
l’architettura della Civiltà della Speranza.
Può sembrare fuori tempo nel periodo pasquale parlare di presepe; ma ad un occhio attento, ad una serena e robusta formazione teologica non sfugge l’unità del Mistero rivelato: Incarnazione e
Redenzione fanno sempre sintesi nella carne del Verbo.
Il cuore della nostra fede che è il Mistero pasquale è già nascosto nella culla di Betlemme; ed è da tenere sempre insieme il legno della culla natalizia e lo spessore della croce pasquale.
Colui che era, che è e che viene – vero Dio e vero uomo – Colui che è Nato nella notte betlemita è lo stesso Risorto nella notte gerosolomitana, ed è il Vivente per sempre: Egli è la Speranza risorta! Cristo, mia Speranza, è risorto! Sì, ne siamo certi, Cristo è veramente risorto!
Possiamo attingere dalla semplice architettura del presepe un’icona per le nostre città? Fermarono i cieli, la loro armonia
Cantando Maria la nanna a Gesù Con voce divina la Vergine bella
Più vaga che stella cantava così: Dormi dormi, fai la nanna mio Gesù.
Così cantava e ci ha insegnato a cantare Sant’Alfonso, per farci contemplare con Maria i luoghi, i personaggi, gli animali, le persone, il Bambino, e per ascoltare una melodia che, dalle contrade di
Betlemme ha invaso e invade i nostri luoghi, le culture, e tutti i quartieri del cuore umano. Scolari alla semplice scuola del presepe, forse riusciamo a mettere un po’ di ordine nel nostro mondo, dove qualcuno giocando ha confuso i diversi personaggi.
Il presepe non è l’icona di un mondo antico che non esiste più, ma archetipo, genesi di ogni mondo che sempre rinasce, spaccato esistenziale di umana, civile e cristiana convivenza, dove ognuno occupa il suo posto. Ricchi nella diversità, poveri nella divisione, ma
tutti attratti da un’unica meta, convergenti verso di essa: una stella, una stalla, un bambino, un canto, un fruscìo di ali, un dono per tutti per una recuperata sensibilità esistenziale.
«Te piace ‘o presepe?». Le risposte nel tempo sono molteplici e mai univoche, e rivelano culture, formazione e personalità diverse.
La stizzosa risposta negativa, stigmatizzata da Eduardo De Filippo – «Nun me piace ‘o Presepe!» – vuole contrastare e mettere in discussione, non tanto la bellezza del presepe, ma l’autorità del
padre, la ricchezza della tradizione, quasi snobbando un’educazione ricevuta, per sentirsi emancipati e moderni. Dinanzi poi alla sofferenza e alla morte, che tutto riporta nell’orbita del reale, lo stesso presepe, gli affetti, le cose di sempre e forse mai apprezzate, acquistano un significato diverso, un sereno ripensamento ed una pacata accettazione maturata nel tempo, dalle situazioni e dagli schiaffi della vita. Quale famiglia e quale società ruotano accanto
al presepe? Reale, e non ideale, è lo scenario umano che anima il presepe dove gli uomini e le donne sono colti nel loro attimo fuggente, in un qui e un adesso, ordinari scenari della vita.
Accanto ed intorno al presepe da sempre urla ed impazza la vita, con le sue luci e le sue ombre; e il presepe rimane là come nell’ombra e non sempre la sua luce è accolta dai componenti della famiglia.
La cellula della famiglia si è frantumata, un terremoto l’ha distrutta, e chiede oggi nuova e strutturata
stabilità; e il presepe, quale punto di riferimento, con
il suo grido silenzioso può suggerire ancora un’architettura di pace, di accoglienza e di integrazione, direi quasi una sana ecologia acustica ed oculistica; ecologia delle orecchie, degli occhi, ma soprattutto del
cuore, che di pietra deve ridiventare di carne, capace di amare e non di armare, semplicemente umano, ed ogni presepe è un invito a questo trapianto.
«Fermarono i cieli…».
È come se, all’improvviso, dinanzi al Natale del Verbo, tutto il mondo si fermasse, come fa l’atleta per riprendere fiato e slancio.
Fermarsi! Il presepe è un invito a fermarsi, un attimo di sospensione, di meraviglia e di stupore;ma anche di domanda, riflessione, meditazione, ricerca, per recuperare l’anima, la spiritualità del
pellegrino, smarrita nel ciarpame di inutili cose, o
forse rimasta indietro. E non ci stanchiamo di chiederci: «Quale città
vogliamo costruire? Come governare le nostre città? E quale dialogo tra Chiesa e Mondo, tra chiese e mondi? Pellegrini fiduciosi verso la Porta spalancata della speranza, o verso il baratro, il nulla?».
Il presepe, nella sua architettura antica, semplice ed armonica, ci invita a fermarci un attimo per pensare e ripensare a questo nostro mondo, e non lasciarsi ferire dai calcinacci del mondo vecchio che
muore, non essere distratti in mezzo a tanta bellezza che nasce, ma sempre pellegrini ricchi di speranza, e costruttori appassionati della Civiltà della Speranza, e non più abbarbicati a vecchie logiche di
odio, di guerra e divisioni, che non edificano.
L’architettura della Civiltà della Speranza, che il presepe ci suggerisce, ci aiuta a comprendere quale è il centro e il senso di tutta la vita: pellegrini, sì, ma verso una meta; pellegrini, sì, ma seguendo una stella, un bimbo, un ideale di bene, un sogno; pellegrini, sì, ma non distratti che, per raccogliere i fiori lungo la strada, si attardano e smarriscono la meta. Pellegrini, sì, richiamati da una luce nella notte;
pellegrini e non profughi, vagabondi, o turisti distratti e indifferenti.
Siamo abituati a cogliere il fiore della speranza soprattutto nella culla di un bimbo che nasce, che viene alla luce.
E facciamo bene, mentre ci accorgiamo come è corto il fiato della speranza nel mondo occidentale, che ha diminuito di molto le botteghe delle culle, registrando un deficit di speranza mai raggiunto.
Se osserviamo attentamente l’architettura del presepe, ci accorgiamo che accanto alla culla del neonato è deposto un segno di speranza, che viene da lontano, e che va oltre il perimetro del tempo,
e ci apre alla speranza escatologica, oggi merce rara nei nostri centri commerciali. Mi riferisco alla mirra, uno dei doni dei Magi:
«Oro e incenso proclamano il Re e Dio immortale, la mirra annuncia l’Uomo deposto dalla Croce»
(cfr Liturgia della Solennità dell’Epifania).
La mirra, unguento molto noto al tempo gesuano, ci ricorda che quel bambino sarà l’Uomo deposto dalla Croce. C’è sempre una speranza che nasce, ed una speranza che, morendo rinasce, risorge
e mai muore, e si nasconde nelle tante fragilità esistenziali. È questa grande speranza, nascosta in un pargolo, in piccoli segni sub contrario, la virtù di cui abbiamo estremamente bisogno nella vita e nella città per essere allenati a camminare, saldo nella
speranza contro ogni speranza (Rm 4, 18).
Virtù piccola che deve crescere, che bisogna aiutare a crescere, e non abortirla ad ogni stagione impoverendoci sempre più.
Se si offusca l’oltre, il di più, il futuro, anche il presente perde mordente e la vita diventa soltanto una folle corsa tra una culla e una tomba, alla fine insensata.
Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno (Lc 23, 42), chiede il ladrone in croce accanto
a Gesù: se la speranza muore sulla Croce di Cristo, la Croce non è più l’Unica Spes, l’unica speranza, e si smarrisce la porta stretta per entrarvi. Il presepe è il segno incipiente della grande speranza, quella che non marcisce e non muore; trave necessaria e pietra angolare per reggere tutto l’edificio esistenziale, àncora posta in alto e che sempre
ci attira e ci salva. Contemplando il presepe, stiamo attenti a dove,
come, e con chi costruiamo per non essere confusi in eterno.
Discorso arduo questo della dimensione escatologica della speranza, non solo cristiano, ecclesiale, ma quanto umano e quanto presente, forse anche in modo confuso una volta caduti tutti i messianismi terreni ed ideologici, nei discorsi di poveri pellegrini, che a volte come sbandati, cercano un oltre, un di più, un senso nelle nebbie. Nelle fatiche del pellegrinaggio quotidiano non si arrendono dinanzi ad una porta chiusa, ma sempre anelano ad uno spiraglio di luce, perché assetati di infinito, e non si accorgono che quel senso della vita è nascosto in qualche scena del presepe.
L’architettura del presepe ci educa ad avere attenzione e rispetto al particulare, ai dettagli per comprendere la bellezza e l’armoniosità di tutta la scena, che diventa mistica della tenerezza.
La profondità, le proporzioni, gli scorci, l’armonia delle parti, il gioco tra antico e nuovo, gli spazi, tutto concorre al dinamismo della bellezza e alla contemplazione che sfocia nella meraviglia.
Il presepe non è abitato da una massa amorfa ma
da un popolo variegato, composto di persone uniche ed irripetibili, originali, e non prodotti in serie.
Ogni statua ha la sua storia, le sue fattezze, lesue movenze, i suoi doni ed atteggiamenti, le sue vesti, i suoi arnesi di lavoro, di studio o professione, il suo stupore ed angoscia, i suoi sogni e le sue paure, le sue lacrime e i suoi sorrisi, le sue aperture e chiusure, le sue corse e i suoi ritardi, il suo bagaglio esistenziale, senza il quale la vita non è, o non è quella vita unica ed irripetibile. Nel presepe c’è un popolo da amare e governare, quasi fermato in quella notte di stelle come in in
una istantanea, ma pronto, all’apparire del giorno, a riprendere la strada con quella luce nel cuore discesa dall’alto.
È questa attenzione al dettaglio, ai particolari, alle zone di luce e di ombre, ai diversi personaggi che fa di ogni presepe un’opera d’arte e una ricca scuola di umanità, una città abitabile e vivibile,
unica per cultura e tradizione.
11.
Dall’architettura del presepe possiamo molto imparare per la costruzione, o riqualificazione, delle
nostre città, a volte agglomerati confusi, dove si fa
fatica a respirare mortificando la qualità della vita. Oggi ci accorgiamo come le tante edilizie sociali o popolari e altre costruzioni tirate su in fretta per non essere abitate, nate forse con buone intenzioni, si sono rivelate fallimentari, ghetti senza servizi
e vivibilità; oggi ancora di più penisole ingestibili in tante nostre città, zone inospitali, ricettacoli di varie immondizie, schiaffo alla dignità delle persone, convegno di tutte le fragilità, esistenziali e morali, grappoli di solitudini che generano marginalità sociali.
Se guardiamo con attenzione al presepe, e trasportiamo la sua architettura nella gestione delle nostre città, tutti potrebbero usufruire di una rinnovata realtà abitativa, dove al centro c’è la persona con tutti i suoi sogni e i suoi bisogni; le persone
e non le cose, che si usano e poi si gettano.
Così l’architettura del presepe, costruita con
passione, e liberata da un alone solo mistico, religioso e decorativo, può contribuire al benessere delle nostre realtà abitative, luoghi vivibili, spazi adeguati, dove ognuno può esprimere al massimo la sua vocazione alla bellezza. Può essere questo, tra gli altri, il segno e il sogno del nostro Anno Giubilare, quasi una restituzione dovuta alla dignità della nostra gente, ai pellegrini che ritrovano il calore della casa, chiamati ad abitare le speranze quotidiane nell’attesa che si compia la beata speranza.
Carissimi, spiritualmente siamo già tutti – Popolo ed Istituzioni – in Piazza San Pietro; ognuno con la sua storia e il suo ruolo, ma tutti Pellegrini di Speranza, seme sempre da spargere su
questa terra. In quella Piazza unica al mondo, nell’abbraccio del Bernini, dinanzi al nostro Presepe offerto
con devozione al Santo Padre e al Mondo, con in
mano la fiaccola della fede, riprendiamo i nostri
canti, i canti della vera tradizione, i canti dei pellegrini che, dopo tanti erramenti, tornano a casa
e si fermano là dove vedono brillare una Stella, e
dove la vita è sempre un nuovo inizio.
E dal presepe, affascinati ed attratti dall’architettura della speranza, ognuno riprenda il proprio
pellegrinaggio verso la vita reale e i luoghi della
vita, aprendo sempre porte al dono esistenziale;
e così, rifacendo la strada con giubilo, guardiamo
con occhi diversi e colmi di stupore la nostra terra e le nostre terre per diventare ognuno un profetico seme di speranza.
Forse trasformati dalla bellezza del presepe,
molti si accorgeranno che i Pellegrini di Speranza veramente hanno attraversato la Porta Santa, aprendo innanzitutto la porta del cuore, e
ora tornano con grande gioia per aprire le tante
porte che ancora rimangono sbarrate in mezzo
a noi.
Dopo aver contemplato il presepe torniamo:
• come Maria che custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2, 19);
• come i pastori, glorificando e lodando Dio
per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro (Lc 2, 20);
• come i Santi Magi, avvertiti in sogno di
non tornare da Erode, per un’altra strada
fecero ritorno al loro paese (Mt 2, 12)